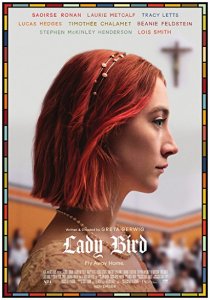Di molti film, anche buoni, visti negli ultimi mesi non ho appuntato niente, l’Oscar offre l’occasione per recuperare qualcosa. Cominciando dal Miglior Film, Oppenheimer parte come favorito ma non è di certo il mio favorito. Nolan racconta di questo mondo assurdo dove, qualsiasi cosa stia facendo, c’è almeno un quartetto d’archi a commentare straziato le tue azioni. Più spesso, c’è un’intera orchestra in crescendo drammatico a seguirti mentre ti versi il caffè o compili la lista della spesa. Tutta questa tensione, inevitabilmente, porta i Paesi verso la corsa all’atomica. Nolan continua a fare grossi film che non mi cambiano la vita, e in questo caso non sceglie né di romanzare la storia, come fanno classicamente gli americani, né di provare una struttura in qualche modo sorprendente. C’è la messa in scena di una serie di eventi, un po’ mescolati, un po’ decolorati, molto, troppo dialogati, e al centro un assurdo, forse un po’ morboso, striptease della bomba (2,5/5).
Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Anatomia di una caduta di Justine Triet, Povere creature! di Yorgos Lanthimos e La zona d’interesse di Jonathan Glazer, di cui si è già detto, sono tutti ottimi film, e non è affatto poco. Lanthimos con Poor Things procede sul percorso di “normalizzazione” intrapreso con La Favorita, ma preferisco questo al tentativo di ripetere le intuizioni più radicali dei suoi primi lavori. Di Povere Creature si è detto molto, il film è interessante e bello da vedere, Emma Stone è l’ottima protagonista di un’opera che richiama la meraviglia di Melies e Lang, le vedute dell’inferno di Bosch, ci mette ironia, crescita e acquisizione della consapevolezza. Povere Creature richiama, capovolgendoli, i temi di Dogtooth, con una protagonista estranea ai vincoli sociali che sperimenta una progressiva acquisizione della conoscenza, anche lessicale, che invece nel film del 2009 viene negata o manipolata. Oltre a Stone, meno appariscente ma bravo Mark Ruffalo nell’incarnare una realistica e altrettanto preziosa caricatura maschile (4/5). Scorsese, dopo le delusioni di Silence e The Irishmen, torna con un filmone, Killers of the Flower Moon, epico e cattivo, fatto di personaggi orribili e monumentali (perfetti De Niro e DiCaprio), capaci di ingannare perfettamente anche loro stessi (4/5). A portare sullo schermo l’ambiguità e l’incertezza c’è anche Anatomia di una caduta, un film affasciante, compatto, rigoroso, sulla fragilità della realtà, con al centro una splendida Sandra Hüller, quest’anno anche in Zone of Interest (4/5).
American Fiction di Cord Jefferson è quel che si suol dire un film carino. Parte bene ironizzando sull’incapacità contemporanea di contestualizzare parole e pensieri nei tempi e nei luoghi in cui hanno avuto origine, nel suo svolgersi conserva il tema integrandolo con l’appiattimento verso rassicuranti luoghi comuni che fa la fortuna di molti autori (scrittori, in questo racconto). Si perde, però, in una specie di commedia degli equivoci, e alla fine si pone come un film gradevole, ma non particolarmente incisivo e inutilmente sospeso (3/5). Past Lives di Celine Song è un film molto romantico, nostalgico, sentimentale, ce lo dice fin dalla prima inquadratura e lo ripete in continuazione. Parla di vite possibili, incroci statistici e coincidenze perdute, ma si dimentica di costruire i suoi personaggi. Nonostante il suo successo, mi è quindi sembrato un film teorico e senza guizzi, un film sul destino o sulla sua mancanza, con più di uno sguardo a Wong Kar-wai, che non suscita interesse reale nella destinazione dei suoi piattissimi protagonisti, che si limitano a enunciare soltanto le caratteristiche che li renderebbero esseri umani, oltre che le parti di un film a tesi (2,5/5). Di Barbie mi sento di dire solo che dalla coppia Gerwig Baumbach mi aspettavo decisamente di più. Prima dell’uscita del film pensavo a come sarebbe difficile scrivere una sceneggiatura realmente interessante su un prodotto come Barbie, e infatti non lo hanno fatto, hanno titillato gli istinti più elementari di una sorta di femminismo glam e instagrammabile, portandolo nei canoni più risaputi della commedia demenziale americana. Peccato. (2,5/5).
Anche nella categoria Miglior Film Internazionale molti titoli interessanti: Perfect Days, un Wenders in formissima che anche da noi hanno visto in tanti, dimostrando che fare cinema vero può pagare, ancora la Zona di Interesse di Glazer, e Io Capitano di Matteo Garrone, un’odissea che forse non è il suo film più sorprendente (per molti versi credo Garrone sia il nostro regista più bravo), ma un film importante e necessario (3,5/5).
Infine il Miglior Film d’Animazione, categoria potenzialmente interessantissima ma quasi sempre schiacciata su posizioni statunitensi e più precisamente disneyane. Questo potrebbe essere però l’anno della seconda, strameritata statuetta ad Hayao Miyazaki, dopo La Città Incantata del 2003, con il visionario Il Ragazzo e l’Airone. Gli altri titoli sono il Pixar (Disney) Elemental (3/5), un po’ confuso e non proprio memorabile, ma comunque migliore specialmente delle ultime prove a marchio puramente Disney, Nimona e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Nimona è un cartone molto Netflix, fatto di tratti stilizzati, montaggio veloce e messaggi inclusivi condivisibili quanto veicolati in modo didascalico (3/5), mentre Spider-Man è uno straordinario esempio di avanguardia superammiccante. Nell’ennesima variazione sul tema degli universi paralleli, la storia è terribilmente maltrattata, una sovrapposizione di momenti che riprendono altre storie, ne mescolano i topoi senza portare a compimento o alla maturità nessuna narrazione. Dal punto di vista estetico e cinetico riprende varie correnti sperimentali ampiamente sperimentate, specialmente nell’animazione, portate in un montaggio epilettico, così costantemente frammentario e ultraveloce da non avere ritmo (2,5/5).
Update: ho dimenticato, in questo appello, La Meravigliosa Storia di Henry Sugar, cortometraggio (ma di 40′) di Wes Anderson e oggi prima statuetta per il regista. I quattro corti che Anderson ha tratto da scritti poco noti di Dahl sono su Netflix e sono abbastanza sorprendenti. Sia per la versione matura dello scrittore che offre uno straordinario punto di partenza, sia per quello che mi sembra sia un nuovo periodo d’oro del regista. Henry Sugar unisce l’impostazione teatrale e l’estetica consolidata di Anderson, che già con Asteroid City era tornato a realizzare film pienamente convincenti, dall’impostazione autoriale e ispirata.