 Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse (James Gray 2022), a dispetto del titolo emmerichiano, quello di Gray è un piacevole titolo di formazione, presumibilmente d’ispirazione autobiografica, immerso negli anni ’80 americani. Ben equilibrato, più di una manciata di ottimi interpreti (Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Anne Hathaway…), regia solida, meriterebbe di essere conosciuto di più. 4/5
Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse (James Gray 2022), a dispetto del titolo emmerichiano, quello di Gray è un piacevole titolo di formazione, presumibilmente d’ispirazione autobiografica, immerso negli anni ’80 americani. Ben equilibrato, più di una manciata di ottimi interpreti (Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Anne Hathaway…), regia solida, meriterebbe di essere conosciuto di più. 4/5
The Party (2017), tragicommedia lampo, teatrale e in bianco e nero di Sally Potter, con un mucchio di attoroni (Kristin Scott Thomas, Cillian Murphy, Timothy Spall, Patricia Clarkson, il nostro amico Bruno Ganz) variamente esasperati dall’esistenza. Assolutamente godibile. (3,5/5)
Saltburn (Emerald Fennell 2023), per qualche momento è stato il caso del momento, su Amazon. L’impianto teorico è molto vicino a Il Talento di Mister Ripley, ma è un film estremamente estetizzante e didascalico, e ridotto a prodotto social il suo impatto è stato limitato a una scena e poco più. Molto diversa, ma anche molto più riuscita, la più o meno contemporanea serie Ripley. 2,5/5
Il Talento di Mr. Ripley (Anthony Minghella 1999), filmone decisamente anni ’90, recuperato sulla scia della serie. Impianto pop, montaggio serrato, dimostra tutti i suoi anni e anche qualcuno in più, ma ha il suo perché. 3,5/5
C’è Ancora Domani (Paola Cortellesi 2023), film perfetto per le sfrenate polarizzazioni del pubblico online, ho il problema di non potermi accomodare da nessuna delle due parti. Pur condividendo a pieno le basi teoriche e anche didattiche, non posso negare che mi sembri un film con più di qualche problema di scrittura e scolastico dal punto di vista registico, che si preoccupa di più di realizzare scene con messaggi importanti, che di costruirle in maniera coerente. Comunque una interessante opera prima, dal successo innegabile. 3/5
Foglie al Vento (Aki Kaurismäki 2023), un film così Kaurismäki che il nostro non ha pensato di doverci mettere molto altro. Quadri fissi, silenzi, una storia kaurismakamente romantica, un accenno di mondo esterno allo sfascio. Più che un film una firma, un tag. 2,5/5
Il Pataffio (Francesco Lagi 2022), film italiano comodamente su Netflix, credo piuttosto oscuro (ma magari sbaglio, e ha anche lui la sua fanbase). Avventure cavalleresche e scalcagnatissime del Marconte Berlocchio (un Lino Musella assolutamente in parte), evidenti i richiami a Brancaleone. Alcune scene sono telefonate e sfilacciate, ma il film porta anche qualche risata e un notevole carico di amarezza. Si lascia vedere. 3/5
Il Mondo Dietro di Te (Sam Esmail 2023), altro titolone Netflix tendente al flop galattico. Film per molti versi ingiustificabile, ha buoni momenti che ricordano un Rumore Bianco meno ermetico, poi sceglie una strada del tutto sconclusionata. 2/5
La Terra dei Figli (Claudio Cupellini 2021), tratto dall’angosciante e postapocalittica graphic novel di Gipi (che già non è fra le sue migliori), ne riproduce il senso di perdita e disperazione, ma dovessi dire che c’è qualche invenzione che mi ha particolarmente colpito, mentirei. Sensazione simile, ma ancora più scarna, per L’ultimo Terrestre (Gianni Pacinotti 2011). 2,5/5 a entrambi
 Los Colonos (Felipe Gálvez, Felipe Gálvez Haberle 2024), cruda e annichilente storia di frontiera (quella fra Argentina e Cile), fatta di spazi di cui appropriarsi, sopraffazioni, violenze (visivamente non troppo esibite, ma molto presenti). Ricorda sia gli spazi di Malick che la mancanza d’aria di Kelly Reichardt. Alcune immagini e scene davvero notevoli. 4/5
Los Colonos (Felipe Gálvez, Felipe Gálvez Haberle 2024), cruda e annichilente storia di frontiera (quella fra Argentina e Cile), fatta di spazi di cui appropriarsi, sopraffazioni, violenze (visivamente non troppo esibite, ma molto presenti). Ricorda sia gli spazi di Malick che la mancanza d’aria di Kelly Reichardt. Alcune immagini e scene davvero notevoli. 4/5
Old Fox (Ya-chuan Hsiao 2023), taiwanese, miglior film visto nella rassegna dedicata al Far East Film Festival, e ottimo film in assoluto. Solida sceneggiatura di stampo classico, sulla conoscenza / confronto / rivalità / identificazione tra un ragazzino tipicamente sfortunato, bullizzato e intelligente, e l’anziano boss di quartiere. Bello, bravo. 4/5
Takano Tofu (Mitsuhiro Mihara 2023) è invece il titolo giapponese che il FEFF l’ha vinto. Storia edificante di padre e figlia, crescita e invecchiamento, susseguirsi di stagioni. Carino, confezionato per esserlo, molto più usuale del titolo citato su. 3/5
Tales of Taipei (AA.VV. 2023), ultimo titolo visto del FEFF, è un film a episodi realizzato da una decina di registi taiwanesi più o meno emergenti. Diverse tematiche, stili, riferimenti di genere, ma, per la verità, poco o niente che convinca davvero. Stracolmo eppure poco consistente. 2/5
Un Divano a Tunisi (Manele Labidi Labbé 2019), deliziosa, piccola commedia con un’altrettanto gradevole Golshifteh Farahani (Paterson). 3,5/5
Drive Away Dolls (Ethan Coen 2024), se l’escursione solitaria dell’altro fratello Coen, il The Tragedy of Macbeth di Joel, è riuscita alla grande, lo stesso non si può dire per questo film. Più di un occhio strizzato a Tarantino, anche se si può giustamente parlare di un ritorno alle dinamiche dei loro primi film (Blood Simple, Arizona Junior), ma perdendosi per strada. Alcune cose buone, senza colpa le protagoniste (Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan), ma troppo sfilacciato il tutto, alla ricerca di un grottesco che, purtroppo, non fa ridere. Cosa che succede anche in alcuni titoli del duo, specialmente anni ’00. Quindi è interessante vedere esprimersi separatamente le due anime, la geometria e in cazzeggio, il dramma e la farsa, ma questo Drive Away Dolls tira verso il pasticcio. 2,5/5
Unfrosted (Jerry Seinfeld 2024), allegra, demenziale, puramente americana comedy a firma Seinfeld comparsa su Netflix. Per una serata molto spensierata fa il suo lavoro, anche con eventuale pubblico giovanissimo. 3,5/5
[sono stanco]
Inu-oh (Masaaki Yuasa 2021), lungometraggio animato dell’indubbiamente talentuoso Masaaki Yuasa, dal Giappone. Il film ha invenzioni visive notevoli, bizzarre e originali, ma tutta la seconda parte vira sull’opera rock decisamente ripetitiva. Molto interessante, ma un po’ ti affossa. 3/5
Civil War (Alex Garland 2024), mi piace Garland, ha fatto cose che mi piacciono molto (come Devs, ma anche Annientamento), e altre meno, in cui sembra voler infiorettare discorsi intimamente banali. Civil War è una via di mezzo, sembra, in gran parte, l’antefatto di The Road, o la sua trasposizione qualche decennio prima. Il discorso sull’immagine come testimonianza e racconto è molto esplicito, ed è anche la parte, credo, con maggiori licenze riguardo la verosimiglianza. Gli intermezzi pop con orrori su pezzi dei Suicide e altri sono coinvolgenti, ma la creazione delle clip è molto esibita, dà un senso di posticcio. Non mi è dispiaciuto, ma speravo mi sarebbe piaciuto di più. 3/5
 Monster (Kore’eda Hirokazu 2023). Il giapponese Kore-eda è sempre bravo, non credo ci siano in giro molti altri autori con la sua solidità di scrittura e regia, con una visione del cinema così definita ed efficace. Anche questa una storia di crescita, di formazione, ben intrisa delle rigidità e le contraddizioni della società nipponica. Filmone. 4/5
Monster (Kore’eda Hirokazu 2023). Il giapponese Kore-eda è sempre bravo, non credo ci siano in giro molti altri autori con la sua solidità di scrittura e regia, con una visione del cinema così definita ed efficace. Anche questa una storia di crescita, di formazione, ben intrisa delle rigidità e le contraddizioni della società nipponica. Filmone. 4/5
Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki 2023), l’ultimo Godzilla della cucciolata, che si rivela a 70 anni dalle intemperanze del capostipite, è un Godzilla pienamente anni ’50: ingombrante, divertente, atomico, animalesco. Infatti funziona. 3,5/5
[ho finito, ma a quale prezzo?]


 Non è semplice pesare correttamente l’ultimo film dei Coen. Da una parte La Ballata di Buster Scruggs mantiene esattamente ciò che promette, senza sorprendere o spiazzare, dall’altra ci sono pochi autori a poter mantenere promesse del genere, oltre ai fratellini del Minnesota. Bisogna però anche considerare che negli ultimi 10 anni hanno saputo realizzare dei titoli incredibilmente belli (
Non è semplice pesare correttamente l’ultimo film dei Coen. Da una parte La Ballata di Buster Scruggs mantiene esattamente ciò che promette, senza sorprendere o spiazzare, dall’altra ci sono pochi autori a poter mantenere promesse del genere, oltre ai fratellini del Minnesota. Bisogna però anche considerare che negli ultimi 10 anni hanno saputo realizzare dei titoli incredibilmente belli (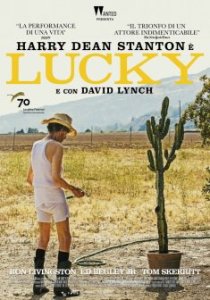 Pubblicato su Bologna Cult
Pubblicato su Bologna Cult Il western, come la fantascienza, è un genere nobile, adatto a svolgere più o meno ogni discorso. Dagli anni ’70, attraverso la destrutturazione di Altman, Peckinpah, Hill e gli altri, si può leggere nel western l’evoluzione di tutto il cinema, fino a contarne gli anelli di crescita. È, ancora oggi, un campo in cui poter sperimentare immersioni nell’umano, tanto quanto iperviolente ibridazioni pop.
Il western, come la fantascienza, è un genere nobile, adatto a svolgere più o meno ogni discorso. Dagli anni ’70, attraverso la destrutturazione di Altman, Peckinpah, Hill e gli altri, si può leggere nel western l’evoluzione di tutto il cinema, fino a contarne gli anelli di crescita. È, ancora oggi, un campo in cui poter sperimentare immersioni nell’umano, tanto quanto iperviolente ibridazioni pop. Da grande voglio fare la cameriera burberissima di Hell or High Water. Il film di David Mackenzieper per Netflix, che ha strappato anche quattro candidature all’Oscar, è un piacevole ritorno al cinema degli anni ’70, da Peckinpah a Cimino. Con i fratelli rapinatori sgangherati, molta polvere, dialoghi ben scritti e ottimi caratteristi, fra cui la succitata cameriera. Poi, un grande (vecchio) Jeff Bridges (che era in Una calibro 20 per lo specialista, uno dei titoli più in linea con questo), splendido ranger rompipalle che merita tutta l’esasperazione del collega nativo americano. Altro punto a favore l’accompagnamento di Nick Cave e Warren Ellis. Stonano un po’, invece, i continui richiami alle colpe delle banche, inseriti in maniera pretestuosa nei dialoghi per dare uno spessore politico che apprezzo molto quando c’è davvero, ma che qui risulta posticcio. Rimane, comunque, uno dei film meglio costruiti e più piacevoli del nostro passato prossimo.
Da grande voglio fare la cameriera burberissima di Hell or High Water. Il film di David Mackenzieper per Netflix, che ha strappato anche quattro candidature all’Oscar, è un piacevole ritorno al cinema degli anni ’70, da Peckinpah a Cimino. Con i fratelli rapinatori sgangherati, molta polvere, dialoghi ben scritti e ottimi caratteristi, fra cui la succitata cameriera. Poi, un grande (vecchio) Jeff Bridges (che era in Una calibro 20 per lo specialista, uno dei titoli più in linea con questo), splendido ranger rompipalle che merita tutta l’esasperazione del collega nativo americano. Altro punto a favore l’accompagnamento di Nick Cave e Warren Ellis. Stonano un po’, invece, i continui richiami alle colpe delle banche, inseriti in maniera pretestuosa nei dialoghi per dare uno spessore politico che apprezzo molto quando c’è davvero, ma che qui risulta posticcio. Rimane, comunque, uno dei film meglio costruiti e più piacevoli del nostro passato prossimo. Molto politico, davvero politico, è invece L’Altro Volto della Speranza. Aki Kaurismaki credo sia l’unico grosso autore ad aver affrontato in maniera così diretta ed esplicita, in un film di fiction, la questione dei profughi siriani, e il modo in cui vengono visti e trattati dai Paesi che dovrebbero ospitarli. Il tema è estremamente concreto e reale, e la capacità di Kaurismaki sta proprio nell’immergere, intatta, la realtà all’interno della sua poetica. Lo sguardo è il suo, distaccato e costantemente ironico, le situazioni sospese e lievemente surreali, i protagonisti immersi ciascuno nel proprio mondo, ma immediatamente disposti a prendersi cura di chi ne mostra l’esigenza. L’Altro Volto della Speranza riesce a miscelare orrori e violenze reali, vicende individuali, momenti di comica assurdità, senza dare l’impressione che niente di tutto questo sia fuori posto. Molto bello.
Molto politico, davvero politico, è invece L’Altro Volto della Speranza. Aki Kaurismaki credo sia l’unico grosso autore ad aver affrontato in maniera così diretta ed esplicita, in un film di fiction, la questione dei profughi siriani, e il modo in cui vengono visti e trattati dai Paesi che dovrebbero ospitarli. Il tema è estremamente concreto e reale, e la capacità di Kaurismaki sta proprio nell’immergere, intatta, la realtà all’interno della sua poetica. Lo sguardo è il suo, distaccato e costantemente ironico, le situazioni sospese e lievemente surreali, i protagonisti immersi ciascuno nel proprio mondo, ma immediatamente disposti a prendersi cura di chi ne mostra l’esigenza. L’Altro Volto della Speranza riesce a miscelare orrori e violenze reali, vicende individuali, momenti di comica assurdità, senza dare l’impressione che niente di tutto questo sia fuori posto. Molto bello.




 Pubblicato su
Pubblicato su 
 Godzilla (Gareth Edwards 2014). Non è il film che speravo mi svelasse definitivamente Gareth
Godzilla (Gareth Edwards 2014). Non è il film che speravo mi svelasse definitivamente Gareth  Maleficent (Robert Stromberg 2014). Angelina Jolie ci sta, per sguardo e personaggio è in parte, ma il film di Stromberg non ha le qualità per rendere davvero memorabile alcunché. Le mire sono alte, nella rivisitazione della bella addormentata dal punto di vista della strega fanno capolino idee anticonformiste e femministe. Riuscire a inserire temi di un certo spessore in un blockbuster è impresa tutt’altro che facile, e a Maleficent, che non sa rielaborare i suoi contenuti in maniera convincente, questa non riesce. E alcune scene più movimentate sono esteticamente piuttosto imbarazzanti, fra zoomini, oscillazioni e primissimi piani enfatici.
Maleficent (Robert Stromberg 2014). Angelina Jolie ci sta, per sguardo e personaggio è in parte, ma il film di Stromberg non ha le qualità per rendere davvero memorabile alcunché. Le mire sono alte, nella rivisitazione della bella addormentata dal punto di vista della strega fanno capolino idee anticonformiste e femministe. Riuscire a inserire temi di un certo spessore in un blockbuster è impresa tutt’altro che facile, e a Maleficent, che non sa rielaborare i suoi contenuti in maniera convincente, questa non riesce. E alcune scene più movimentate sono esteticamente piuttosto imbarazzanti, fra zoomini, oscillazioni e primissimi piani enfatici.  The Lone Ranger (Gore Verbinski 2013). Stessa formula dei pirati, ma meno noioso. Di queste serie – o aspiranti tali – il primo episodio è quello che ha più possibilità di cavarsela, e Lone Ranger, spensieratamente cartoonistico, ci riesce. È una questione di formule narrative, un film d’intrattenimento ha bisogno di una parabola favolistica completa, mentre gli episodi successivi al primo possono solo prolungare e replicare dei passaggi isolati. L’ultimo film di Verbinski con i birignao di Depp inizia forte, poi inevitabilmente si assesta ma regge, e conserva un’ironia abbastanza fresca per tutta la non indifferente durata. Pecca maggiore un cattivo che parte bene, anche violento per una produzione Disney, poi gli viene negato un adeguato confronto finale.
The Lone Ranger (Gore Verbinski 2013). Stessa formula dei pirati, ma meno noioso. Di queste serie – o aspiranti tali – il primo episodio è quello che ha più possibilità di cavarsela, e Lone Ranger, spensieratamente cartoonistico, ci riesce. È una questione di formule narrative, un film d’intrattenimento ha bisogno di una parabola favolistica completa, mentre gli episodi successivi al primo possono solo prolungare e replicare dei passaggi isolati. L’ultimo film di Verbinski con i birignao di Depp inizia forte, poi inevitabilmente si assesta ma regge, e conserva un’ironia abbastanza fresca per tutta la non indifferente durata. Pecca maggiore un cattivo che parte bene, anche violento per una produzione Disney, poi gli viene negato un adeguato confronto finale.  Smetto Quando Voglio (Sidney Sibilia 2013). Uno dei rari film italiani che passano da queste parti, portato dai molti volti da
Smetto Quando Voglio (Sidney Sibilia 2013). Uno dei rari film italiani che passano da queste parti, portato dai molti volti da  Dragon Trainer 2 (Dean DeBlois 2014). Mentre scrivevo in Lone Ranger di parabole narrative e incompletezze strutturali pensavo a questo. Dragon Trainer 2 si lascia guardare: è movimentato, ci sono molti draghi colorati e dal design fantasioso, l’animazione è fluida. Perde necessariamente la semplicità e la completezza dal primo, non aggiunge niente al suo mondo e così assume un valore semplicemente episodico.
Dragon Trainer 2 (Dean DeBlois 2014). Mentre scrivevo in Lone Ranger di parabole narrative e incompletezze strutturali pensavo a questo. Dragon Trainer 2 si lascia guardare: è movimentato, ci sono molti draghi colorati e dal design fantasioso, l’animazione è fluida. Perde necessariamente la semplicità e la completezza dal primo, non aggiunge niente al suo mondo e così assume un valore semplicemente episodico. 
 A Touch of Sin racconta quattro episodi di ordinaria follia cinese. Jia Zhang-Ke vinse il Leone d’Oro con Still Life, dove rallentate storie personali s’intrecciano con la devastazione portata dalla costruzione di un’enorme diga. Questo suo lavoro del 2013, ancora legato a doppio filo col racconto della Cina moderna, cambia però tono, inserisce numerose scene al sangue e un’amara linea ironica – o meglio sarcastica – che a volte ricorda Leone. Fra giustizieri col fucile, prostitute in divisa ed esplosioni d’ira, il ritratto del Paese è desolante, dominato da figure nel migliore dei casi detestabili, altrimenti possedute da un disprezzo per l’esistenza che si esprime con la noncuranza con cui si dispone della propria vita. Il film di Jia riesce a colpire e deprimere, ma dopo aver visto alcune centinaia di pellicole estremorientali viene da farsi un conto: quante offrono un’apprezzabile impatto estetico, colpendoci con le bellezze naturali o gli scempi industriali o una spietata lotta fra i due elementi? Quante rappresentano figure solitarie che covano silenziosamente il proprio dolore, perdute nel disinteresse generale, per degenerare in violenza distruttiva e/o autolesionista? La risposta è: quasi tutte.
A Touch of Sin racconta quattro episodi di ordinaria follia cinese. Jia Zhang-Ke vinse il Leone d’Oro con Still Life, dove rallentate storie personali s’intrecciano con la devastazione portata dalla costruzione di un’enorme diga. Questo suo lavoro del 2013, ancora legato a doppio filo col racconto della Cina moderna, cambia però tono, inserisce numerose scene al sangue e un’amara linea ironica – o meglio sarcastica – che a volte ricorda Leone. Fra giustizieri col fucile, prostitute in divisa ed esplosioni d’ira, il ritratto del Paese è desolante, dominato da figure nel migliore dei casi detestabili, altrimenti possedute da un disprezzo per l’esistenza che si esprime con la noncuranza con cui si dispone della propria vita. Il film di Jia riesce a colpire e deprimere, ma dopo aver visto alcune centinaia di pellicole estremorientali viene da farsi un conto: quante offrono un’apprezzabile impatto estetico, colpendoci con le bellezze naturali o gli scempi industriali o una spietata lotta fra i due elementi? Quante rappresentano figure solitarie che covano silenziosamente il proprio dolore, perdute nel disinteresse generale, per degenerare in violenza distruttiva e/o autolesionista? La risposta è: quasi tutte. Ancora mi interrogavo sulle differenze culturali, sull’impatto devastante del capitalismo, sull’omologazione, lo sfruttamento e l’indifferenza, su quanto venga perso nella traduzione e sulla definizione e grandezza che dovrebbe avere lo schermo di un cinema per poter essere definito tale, che la sera mi ritrovo a vedere l’opera prima, da regista e sceneggiatore, di James Franco. Che esordisce con As i Lay Dying, un western marcato Faulkner desolante e deprimente. In una maniera simile al film di Jia, anche questo abitato da figure apatiche, che dimostrano scarsissima propensione alla salvaguardia della propria esistenza. Una famiglia del Mississippi, nucleo compatto di bifolchi squattrinati, perde la propria matriarca. La volontà di seppellirla in città porta tutti verso un viaggio che gli consentirà di esprimere il peggio di sé, come posseduti da una maledizione innescata dalla smisurata stupidità, cui si aggiunge lo spontaneo accanimento della sfiga. Anche qui figure allo sbando, sacrifici superflui e drammi svuotati di pathos. Franco costruisce un piccolo film, anche troppo piccolo per competere con quelli che sembrerebbero un paio di riferimenti contemporanei,
Ancora mi interrogavo sulle differenze culturali, sull’impatto devastante del capitalismo, sull’omologazione, lo sfruttamento e l’indifferenza, su quanto venga perso nella traduzione e sulla definizione e grandezza che dovrebbe avere lo schermo di un cinema per poter essere definito tale, che la sera mi ritrovo a vedere l’opera prima, da regista e sceneggiatore, di James Franco. Che esordisce con As i Lay Dying, un western marcato Faulkner desolante e deprimente. In una maniera simile al film di Jia, anche questo abitato da figure apatiche, che dimostrano scarsissima propensione alla salvaguardia della propria esistenza. Una famiglia del Mississippi, nucleo compatto di bifolchi squattrinati, perde la propria matriarca. La volontà di seppellirla in città porta tutti verso un viaggio che gli consentirà di esprimere il peggio di sé, come posseduti da una maledizione innescata dalla smisurata stupidità, cui si aggiunge lo spontaneo accanimento della sfiga. Anche qui figure allo sbando, sacrifici superflui e drammi svuotati di pathos. Franco costruisce un piccolo film, anche troppo piccolo per competere con quelli che sembrerebbero un paio di riferimenti contemporanei,  “Un film di Quentin Tarantino” è la prima indicazione, prima del titolo, come faceva anche
“Un film di Quentin Tarantino” è la prima indicazione, prima del titolo, come faceva anche